Potete leggere la prima parte di questa puntata qui.
🎞️ Visioni
Una rubrica in cui parlo di film o serie tv che ho visto di recente.
Non ho visto film questo mese1, ma mi ha colpito la singolare coincidenza di due notizie legate al mondo del cinema. Tra settembre e ottobre, a distanza di due settimane l’uno dall’altro, sono morti Renato Casaro (89 anni) e Drew Struzan (78 anni): due nomi che forse diranno poco anche ai più assidui frequentatori di sale cinematografiche, e che invece hanno realizzato opere famosissime finite sotto gli occhi di tutti.
Entrambi sono stati disegnatori di locandine per il cinema. La parola chiave qui è disegnatori: appartenevano infatti alla vecchia scuola, quella dei poster realizzati con chine e matite.
La notizia della loro scomparsa mi è sembrata passare un po’ in sordina: non frequentando molto i social mi manca il polso su quella parte, ma dei siti che leggo abitualmente solo Rivista Studio e Il Post hanno dedicato loro degli articoli2. Mi dispiace, ma è un po’ la conferma che il cinema è fatto soprattutto da una vasta schiera di professionisti condannati all’anonimato. È per questo che ho deciso di mettere su questo piccolo e indegno omaggio personale, da amante del paratesto cinematografico quale sono3.
Renato Casaro era nato a Treviso nel 1935, e ha disegnato locandine per il cinema dal 1965 al 1998, quando si ritirò anche perché gli studi non volevano più poster disegnati. In oltre trent’anni di carriera ha realizzato locandine famosissime, tanto in Italia quanto a Hollywood, e a scorrere l’elenco dei registi con cui ha collaborato c’è da rimanere a bocca aperta: Coppola, De Palma, Bertolucci, Zeffirelli, Leone. Non ci sono solo i grandi nomi, comunque: Casaro ha lavorato anche a decine di peplum e spaghetti western, magari più anonimi ma dall’estetica chiaramente riconoscibile.
Proprio nei giorni della sua morte era in corso a Treviso una mostra sulle sue locandine western. C’è comunque un sito che raccoglie molte delle sue opere, scansionate in digitale e in buona qualità, oltre a bozzetti e a pezzi della sua collezione privata. Tra tutte, quelle qui sotto sono le mie preferite: il poster internazionale de La storia infinita (uno dei film che ho consumato da bambino), la locandina italiana di Balla coi lupi (per me una delle più iconiche della storia4) e quella di Blow Out (ogni riferimento a un mio amico a sua volta amante del paratesto è puramente casuale).

Forse, però, il riconoscimento più prestigioso è arrivato pochi anni fa, quando Quentin Tarantino lo contattò per commissionargli alcune locandine di film fittizi che sarebbero apparse in C’era una volta a… Hollywood. Questa qua sotto la trovo sublime.

Drew Struzan, invece, era nato in Oregon nel 1947. Per me e molti altri millennial cresciuti con i cult americani, probabilmente, era il Dio delle locandine cinematografiche. Eppure i suoi primi passi furono nel mondo della musica, come illustratore di copertine per album. Fu il design di Welcome to My Nightmare di Alice Cooper che attirò su di lui l’attenzione del cinema, dove Struzan approdò nel 1975.
Dopo un paio d’anni passati a lavorare su B-movie, nel 1977 fu contattato dal collega Charles White III per un aiuto su un progetto. White stava lavorando al poster per la seconda distribuzione al cinema di Star Wars, e chiese a Struzan di realizzare i ritratti dei personaggi mentre lui si sarebbe occupato del resto del design. Il poster – noto ai fan come “the Circus Poster” – divenne in seguito oggetto di culto, anche per la sua storia assurda che vi racconto in nota5.

Da lì la carriera di Struzan prese il volo. Star Wars, Indiana Jones, E.T., I Goonies, Ritorno al futuro, Blade Runner, Harry Potter: esiste una sola opera di culto per quelli della mia generazione, a non essere passata dalle sue mani? Mi è quasi impossibile scegliere le mie locandine preferite, tra tutte quelle che ha realizzato: per motivi storici e affettivi vi metto qua sotto il trittico realizzato nel 1997 per la Special Edition della trilogia originale di Star Wars, che all’epoca circolava in VHS a casa mia e prometteva avventure a non finire. Con tutta probabilità sono le prime locandine di Struzan su cui ho posato gli occhi.

In qualche modo, Drew Struzan ha forgiato il mio immaginario al pari dei grandi film che ha illustrato. Il suo gusto per i ritratti disegnati a mano, il modo in cui “affollava” le locandine, i piccoli dettagli: la quintessenza dei poster cinematografici, almeno per me. Ma vi dirò di più. Quando penso ai romanzi che scrivo, me li immagino sempre come se fossero disegnati da Struzan. Mi vergogno a scriverlo, soprattutto oggi, ma qualche tempo fa avevo provato a far generare all’AI una copertina per il libro che ho in stesura, chiedendo di imitare lo stile di Struzan: il risultato fu penoso, naturalmente.
Forse tutto questo vi suonerà nostalgico, come tutti i discorsi che cominciano con “ai miei tempi”. Ma una cosa è certa: le locandine non sono più quelle di una volta. Casaro e Struzan sono stati i maestri di un’arte ormai quasi del tutto scomparsa. Oggi che non ci sono più, ci restano soltanto le loro opere, da mirare e rimirare come i capolavori che sono. Per fortuna questo piacere nessuno ce lo potrà mai togliere.
🎵 Ascolti
Una rubrica in cui parlo di musica senza avere alcuna competenza.
Questo mese ho ascoltato un bel po’ gli Augie March. Studi statistici hanno dimostrato che il 99% dei lettori di questa newsletter non conosce questo gruppo – ma se fate parte dell’1%, vi prego, rispondete a questa mail o palesatevi nei commenti. Per raccontare chi sono gli Augie March e come li ho scoperti, tuttavia, bisogna fare un salto indietro nel tempo.
Un milione di anni fa, nel 2008, ero una matricola universitaria; tra una lezione e l’altra, frequentavo l’aula computer dell’ateneo per andare su Internet. Eh già bambini, c’è stato un tempo in cui l’accesso a Internet non ce l’avevamo in tasca, ma bisognava recarsi fisicamente in un luogo, accendere un terminale fisso, e così via.
Inebriato dal primo accesso a banda larga della mia vita, scoprii un sito chiamato Last.fm: una piattaforma online di streaming musicale, organizzata per radio tematiche, con un algoritmo che ti consigliava artisti simili sulla base dei tuoi ascolti. Vi suona familiare? Be’, nel 2008 era pura fantascienza.
La mia frequentazione di Last.fm terminò nel marzo 2009, quando l’intero sito finì dietro un paywall di 3€ al mese – cifra che all’alba dei vent’anni ritenni irragionevole6. Fu un periodo breve ma intenso, che mi fece approdare su lidi inediti che definirono il mio gusto musicale di quel periodo, insieme al mai troppo rimpianto canale MTV Brand New. Fatto sta che un giorno l’algoritmo di Last.fm cominciò a propormi gruppi indie rock australiani: roba anche interessante, tipo i Powderfinger di My Happiness, oppure gli Eskimo Joe di From the Sea, ma che durarono il tempo di una stagione.
Tranne gli Augie March, che sono rimasti con me per tutti questi anni. Merito soprattutto della loro canzone più famosa in assoluto, One Crowded Hour, che troneggia da sempre nella mia playlist “Belle scoperte”: un pezzo sontuoso, con un crecendo finale memorabile, che apriva l’album Moo, You Bloody Choir del 2006.
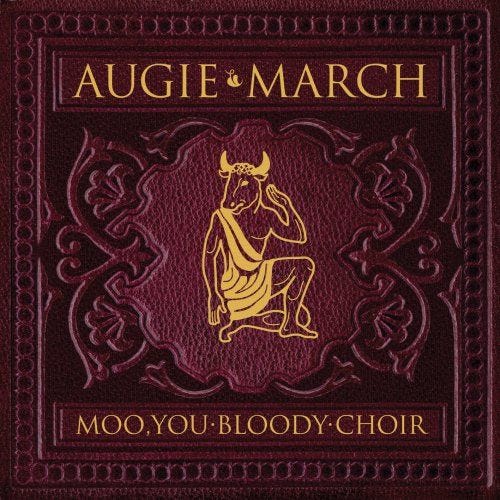
Moo, You Bloody Choir merita di essere ascoltato nella sua interezza, anche solo per il suo essere fuori dal tempo: quattordici tracce, molte delle quali lunghe 5 minuti o giù di lì, tutte musicalmente ricercate e dai testi non facilmente intellegibili – una cifra stilistica degli Augie March. Difficile isolare le mie preferite, ma forse sono Mother Greer, Bottle Baby, Thin Captain Crackers e Just Passing Through – guarda caso proprio quelle che mi consigliò Last.fm anni fa.
Comunque, ero convinto che gli Augie March si fossero sciolti nel 2009, e invece era solo una pausa di riflessione. Nel 2014 sono tornati insieme – con la stessa formazione – e hanno pubblicato altri quattro album. L’ultimo è uscito nel 2024, è stato composto in gran parte in Europa (“from notes made on a mobile phone while in the grip of a species of long Covid and a brutal high European Summer”, scrivono sul sito ufficiale), e si chiama Malagrotta: sì, quella Malagrotta. L’ho ascoltato tutto, e se possibile è un lavoro ancora più ricercato dei precedenti: non a caso le uniche due tracce che ho ascoltato a ripetizione sono anche quelle musicalmente più accessibili, German Beer e Irrational Anthem.

Insomma, questa è la maxi storia di come ho conosciuto e amato gli Augie March. Ho deciso di raccontarvela perché un algoritmo me li ha fatti scoprire, ma forse oggi un algoritmo ve li nasconde nel mare magnum dello streaming: su Spotify hanno una manciata di ascoltatori, su YouTube i loro video hanno due commenti in croce di australiani che si lamentano di quanto siano sottovalutati, sulla Wikipedia inglese mancano persino le voci dei loro ultimi tre album. Insomma, aspettano ancora di essere scoperti davvero, e voi potreste essere i prossimi a farlo.
🕹️ Backlog
Una rubrica in cui cerco di conciliare videogiochi e vita adulta.
Quando nel 2024 sono tornato a videogiocare dopo una pausa di circa quindici anni, una delle cose che più mi hanno colpito è stato il fatto che nel frattempo erano nati nuovi generi videoludici. Alcuni di essi – penso a roguelike, roguelite e metroidvania – sono sulla bocca di tutti, e prima o poi ne proverò qualcuno. Nel frattempo, ho ascoltato le sirene di un altro genere che mi chiamava a sé più degli altri: il walking simulator.
Il nome dice già tutto: nei walking simulator si cammina, e poco altro. Quel poco altro consiste nell’interazione con l’ambiente circostante, in genere per raccogliere oggetti e risolvere puzzle o enigmi; di solito, i giochi di questo tipo non hanno combattimenti o sequenze d’azione. È un’etichetta che spesso e volentieri ha un’accezione negativa: come a dire, sono titoli semplici, cammini e basta, non c’è sfida. Ma io, dopo aver passato 35 ore su Final Fantasy IX7, cercavo proprio un’esperienza del genere. Ed è così che ho approcciato Gone Home (2013, Fullbright), uno dei primi titoli a fregiarsi di questa etichetta.

7 giugno 1995. Katie torna a casa, in Oregon, dopo aver passato un anno a studiare in Europa. Trova l’edificio vuoto, e sulla porta d’ingresso un biglietto della sorella che la invita a non investigare su ciò che è successo.
Lo dico subito: per quanto io abbia cercato di evitare gli spoiler, ero già a conoscenza del tema di fondo del gioco. Questo mi ha sicuramente privato del “colpo di scena”, ma non mi ha impedito di gustarmi il modo in cui la storia viene costruita e portata avanti. In Gone Home, infatti, non ci sono dialoghi e non si incontrano altri essere viventi, ma l’intera vicenda viene ricostruita esaminando gli oggetti rinvenuti in casa. Si legge un sacco in questo gioco: quaderni, appunti, lettere, depliant, compiti in classe, biglietti accartocciati nei cestini. Ognuno di questi elementi racconta un pezzo della storia, e solo trovandone il più possibile si avrà il quadro completo: alcuni, ovviamente, sono fondamentali per l’avanzamento della trama, mentre altri servono a raccontare le varie sottotrame (opzionali, ma donano spessore alla vicenda8).
Gone Home, da molti punti di vista, mi ha ricordato una versione semplificata delle avventure grafiche cui giocavo da bambino: essenzialmente bisogna esplorare degli ambienti alla ricerca di indizi per risolvere dei piccoli puzzle. A differenza di quei giochi, tuttavia, qui non ci sono punti morti o vicoli ciechi: l’ho portato a termine in due ore e mezza, senza alcuno sforzo.

La componente esplorativa, comunque, è solidissima. Girovagare con visuale in prima persona per questa enorme casa vuota, di notte, durante un temporale, è stata un’esperienza che mi ha coinvolto più di quanto potessi immaginare. La grafica è più che buona, forse persino ottima per un gioco indie del 2013, e gestisce in modo mirabile gli effetti di luce: le varie stanze, infatti, sono tutte al buio, ed è il giocatore che di volta in volta deve accendere le luci per orientarsi9. Il titolo gioca tantissimo sull’atmosfera vagamente horror: da questo punto di vista, oltre al lavoro sull’illuminazione, è encomiabile anche quello sul sonoro, che in più di un’occasione mi ha fatto trattenere il respiro. E alla fine, al momento di salire nell’attico, ho avuto davvero i brividi.
Gone Home è stata un’esperienza molto intensa. A un gameplay minimale si accompagnano temi importanti, una trama che si svela in maniera organica, un gusto dell’esplorazione sopraffino; il tutto all’interno di una ricostruzione storica degli anni ‘90 che è quasi maniacale. Alla faccia di chi pensa che i walking simulator siano giochi banali: Gone Home è stata la prima esperienza di questo tipo per me, ma sono certo che non sarà l’ultima.
⭐ Voto: 4 / 5
🔗 Link
Una raccolta dei migliori contenuti in cui mi sono imbattuto in giro per il web questo mese.
Breve storia dell’assurda qualificazione di Capo Verde ai Mondiali. Un bellissimo pezzo di Fabrizio Gabrielli per Ultimo Uomo, sulla storia sportiva che non dovete perdervi questo mese.
[…] sto guardando qualcosa di formidabile senza bisogno di essere eclatante, perché il calcio è sì espressione di potere politico – nelle stesse ore Gianni Infantino arrivava a Sharm-el-Sheik per presenziare al vertice per la tregua a Gaza – ma è soprattutto, per fortuna, ancora quel qualcosa di prezioso che si annida anche nelle cose piccole e allo stesso tempo mastodontiche, come un gol di Livramento, come un soffio di vento che ti spettina i capelli, come Capo Verde che si qualifica ai Mondiali per la prima volta nella storia.
Stiamo tornando analfabeti?Risposta breve: sì. La risposta lunga la trovate in questo articolo de Il Post, e riguarda ovviamente smartphone, comunicazioni video e flessione della lettura.
Gli oligarchi della tecnologia hanno tanto interesse nell’ignoranza della popolazione quanto il più reazionario autocrate feudale.
Uno dei peggiori disastri ecologici dell’ultimo secolo. È quello che ha portato il Lago d’Aral – il quarto al mondo per estensione – a scomparire quasi del tutto in meno di settant’anni. Un reportage di Valerio Clari per Il Post.
La differenza tra allora e oggi […] è raccontata nel museo di Muynak, città che prima si trovava sul bordo del lago: oggi, ad affacciarsi dal piazzale antistante, si vede solo deserto e qualche relitto di barca che ricorda i tempi passati.
The world needs more spaceports. Oman wants to help. Un longform di Laura Jedeed per Rest of World, sul tentativo dell’Oman di creare un proprio spazioporto.
If the spaceport succeeds, by 2027 Oman will join the small number of countries — just a dozen to date — that possess the facilities to launch objects into space.
Tanta roba questo mese. Grazie se avete avuto la pazienza di leggere fin qui. Alla prossima, ciao!
- In realtà ho visto Lego Batman – Il film, che sì ok, carino, citazionista, metatestuale, ma non ha nulla della profondità tematica del primo film Lego (di cui ho scritto a febbraio). ↩︎
- Rivista Studio uno ciascuno: qui quello su Renato Casaro, e qui quello su Drew Struzan (con un refuso sull’età che ad oggi non è stato ancora corretto). Il Post ha invece scritto solo di Struzan (e nei commenti non è mancato chi ha fatto notare l’assenza di un pezzo analogo su Casaro). ↩︎
- Sono da sempre un cultore di locandine e trailer cinematografici. Pensate che anni fa sono stato anche a tanto così dal finire a lavorarci (dove “a tanto così” si legge: “offerta non congrua economicamente”). ↩︎
- Non solo per me: ricordo uno striscione dei tifosi della Roma, intravisto in una puntata di 90° minuto di fine anni ‘90, dedicato al portiere Konsel e fatto a imitazione di questa locandina. Perché la mia testa conserva informazioni inutili come questa? Forse solo per deliziare voi lettori di questa newsletter. ↩︎
- Eccoci. Struzan e White si accorsero solo in un secondo momento che non c’era posto per tutti i crediti, così dovettero inventarsi un modo per ricavare più spazio. Alla fine venne loro un’idea fuori di testa: immaginarono il poster come parte di un muro su cui erano state affisse altre locandine, lo rimpicciolirono e “fuori” aggiunsero gli elementi mancanti. Da qui deriva il nomignolo “Circus poster”, perché il risultato finale assomigliava alle affissioni dei circhi itineranti. ↩︎
- Apprendo da Wikipedia che il sito esiste ancora, seppur in una forma molto diversa: persa la battaglia dello streaming, Last.fm è oggi integrata con Spotify e YouTube ed è diventata una sorta di piattaforma per il tracciamento e la scoperta dei propri artisti preferiti. ↩︎
- 35 ore distribuite su due mesi e mezzo, per la precisione, che hanno confermato ciò che già sapevo: rimane e rimarrà sempre uno dei miei videogiochi preferiti. Ha i suoi difetti, e a questo giro li ho visti tutti: ma chissenefrega, il resto è meraviglioso. Un titolo su cui non potrò mai essere oggettivo. ↩︎
- Una di queste è incentrata sul padre della protagonista, scrittore fallito di romanzi di fantascienza, che ha scritto un libro in cui un uomo torna indietro nel tempo per sventare l’omicidio di Kennedy: il parallelismo con 22/11/63 di Stephen King è curioso, considerato che il libro è di un paio d’anni precedente. ↩︎
- Esiste comunque una modalità di gioco che prevede che le luci siano tutte accese di default, ma credo che tolga all’esplorazione buona parte del suo fascino. ↩︎